
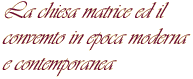
![]() bbiamo
seguito per quanto riguarda Melpignano, pur con i limiti di una scarsa
documentazione a riguardo, le varie fasi di trapasso e di evoluzione tra
i due riti religiosi in conflitto come le testimonianze dell'evoluzione
delle esigenze religiose svolte nella società in considerazione,
che avrebbero portato così al radicale rinnovamento dell'istituzione
ecclesiastica locale. La chiesa matrice infatti, specie nella società
meridionale, assolve alla fondamentale funzione di ricettizia del
clero locale, diventando in tal modo l'elemento più dinamico d'integrazione
sociale e rappresentando fino alla metà del sec. XIX il centro
nevralgico, il perno essenziale, su cui ruota, vive ed agisce la comunità
interessata.
bbiamo
seguito per quanto riguarda Melpignano, pur con i limiti di una scarsa
documentazione a riguardo, le varie fasi di trapasso e di evoluzione tra
i due riti religiosi in conflitto come le testimonianze dell'evoluzione
delle esigenze religiose svolte nella società in considerazione,
che avrebbero portato così al radicale rinnovamento dell'istituzione
ecclesiastica locale. La chiesa matrice infatti, specie nella società
meridionale, assolve alla fondamentale funzione di ricettizia del
clero locale, diventando in tal modo l'elemento più dinamico d'integrazione
sociale e rappresentando fino alla metà del sec. XIX il centro
nevralgico, il perno essenziale, su cui ruota, vive ed agisce la comunità
interessata.
La consistenza delle donazioni, dei diversi legati pii, legati pro anima e legati di giuspatronato che abbiamo già visto, si traducono in un'apprezzabilissima condizione economica goduta dal clero capitolare di Melpignano che per tutto l'antico regime non conoscerà mai momenti di crisi, pur in particolari congiunture difficili e drammatiche piuttosto ricorrenti che conoscerà invece il resto della popolazione. Fatti che porteranno il detto clero di Melpignano a rivestire un ruolo di primo piano nell'ambito della diocesi di Otranto. Accanto infatti alle collegiate di Galatina e di Soleto, la chiesa matrice di s. Giorgio viene elevata dall'arcivescovo, mons. Michele Orsi al grado di instar collegiatae, cioè quasi collegiata, accogliendo la supplica avanzata dal Capitolo di Melpignano. Nella sua conclusione del 28 settembre 1733, il procuratore del Capitolo, don Angelo Burri, raccoglie le speranze di tutti i sacerdoti,
Essendo che da moltissimi anni sia solito questo nostro reverendo Capitolo recitar in ogni giorno senza interpolazione veruna l'uffico divino, e cantar la messa secondo l'oblighi suoi, ed in tutti li giorni festivi di prima classe sollennemente con Ministri, e così pure in ogni terza domenica del mese, e quasi tutti li giorni festivi di seconda classe, molti delle Signorie Vostre mi hanno insinuato che desiderebbero questa nostra matrice Chiesa fosse decorata col titolo instar collegiata, e per la maggior gloria di Dio benedetto, e per maggior rispetto di essa, ed edificazione del popolo.
Nonostante l'apprezzabile consistenza dei suoi beni, questi soffrono della condizione di manomorta come tutti i beni degli enti ecclesiastici nel periodo dell'antico regime, tanto che nel 1706 i sacerdoti partecipanti al Capitolo sono costretti a rivedere il modo di amministrazione della proprietà ecclesiastica, fino ad allora gestita interamente in massa comune dividendo poi tra i diversi partecipanti le rendite ottenute. Con supplica avanzata all'arcivescovo mons. Orsi, da inoltrare poi alla Sacra Congregazione del Concilio, si chiede <<la facoltà per la divisione de’ stabili di detto Capitolo fra sacerdoti partecipanti per maggior utilità di detto Capitolo a’ fine non si deteriorassero>>. Dalla relazione al suddetto Arcivescovo sulla quantità dei fondi di proprietà del clero capitolare, siti nel territorio di Melpignano e nel feudo di Petrore e di Padulano, di fronte al rispettivo valore del <<prezzo>> consistente in ducati 2.421, 00,55 corrisponde soltanto una <<rendita>> di 132,03,10 ducati. Ancora alla domanda <<se li mentionati stabili al presente si trovassero coltivati, serrati li muri e gl'alberi ben tenuti e putati>>, Francesco Caggiula di Melpignano, incaricato dell'accertamento dei suddetti beni, risponde:
sono molto deteriorati li stabili del Capitolo di Melpignano, e gl'alberi sono ridotti in stato di pochissima rendita per li maltrattamenti fattili, perché essendono stati per molti anni in affitto e li conduttori hanno quelli tenuto per il plus offerenti, ne dalla subastatione non si può fare scelta di persona, et alle volte restano a’ tali persone che poco curando il timor di Dio, e niente riflettendo a’ censure Ecclesiastiche, dannificano, e tagliano a’ loro commodo gl'albori, e non danno alle terre l'anno vacante per haverne l'affitto, et il lucro ne si è potuto rimediare a’ danno così irreparabile, e le mura, e pareti sono tutti a’ terra, che per ripararli vi correria spesa almeno di ducati 40 incirca, e più, sicché dico a Vostra Signoria, che stanno tanto deteriorati li stabili del detto Capitolo di Melpignano che’ una compassione.
 Di
fronte a tale situazione certamente poco propizia per l'amministrazione
dei beni di proprietà del Capitolo, la Sacra Congregazione del
Concilio accoglie la suddetta supplica con suo decreto del 5 giugno 1706.
Di
fronte a tale situazione certamente poco propizia per l'amministrazione
dei beni di proprietà del Capitolo, la Sacra Congregazione del
Concilio accoglie la suddetta supplica con suo decreto del 5 giugno 1706.
Di peculiare interesse risulta l'evoluzione della sua struttura istituzionale assunta in prosieguo di tempo, in quanto nella chiesa matrice, come succede anche per l'amministrazione comunale per gl'insiti esercizi e conflitti di potere, si coagulano gli interessi e le aspirazioni delle famiglie più in vista della società melpignanese.
Gli <<Statuti, e costituzioni immemorabili, e nuove della Madrice Chiesa ad instar collegiatae e del reverendo Capitolo di questa terra di Melpignano>>, redatti il 7 gennaio 1736 a cura dell'arciprete don Nicola Antonio Audilia, rivelano la sua struttura istituzionale raggiunta in quel dato momento. Il documento, di cui si offre in appendice la relativa trascrizione, è particolarmente interessante perché tratteggia l'evoluzione istituzionale di una parrocchia della Grecìa salentina, frutto del persistente processo di omologazione attuato secondo i dettami del concilio di Trento. L'analisi delle prerogative e delle competenze contemplate nei suddetti Statuti connesse ai diversi incarichi rivestiti nella struttura capitolare, necessari ad assicurare un ordinato svolgimento della propria vita amministrativa, contribuiscono ad illuminare i rapporti sia all'interno del clero capitolare, come tra questo e la comunità melpignanese che dalla parrocchia appunto e dai suoi sacerdoti trae conforto e comprensione in ogni momento della sua quotidiana lotta per la vita. Se si considera poi che le disposizioni in essi contenute hanno sostanzialmente regolato per secoli la vita del clero capitolare, pur con i limitati adeguamenti apportati nelle epoche successive, fino alla sua soppressione con leggi postunitarie del 1866 e 1867, si comprende il suo estremo interesse.
Il documento, come già abbiamo evidenziato trattando a proposito del rito bizantino, ricorda l'antica chiesa matrice <<coltivata col rito greco>> e la costruzione della nuova nella pubblica piazza nel 1440. I punti successivi dello Statuto affermano la natura della chiesa matrice ormai consacrata al rito latino, ricettizia del clero locale, in cui vengono accolti cioè i clerici <<solo cittadini>> di Melpignano, per la sua rilevanza elevata dalle autorità ecclesiastiche ad instar collegiatae.
Oltre alle prerogative dell’Arciprete vengono precisate quelle relative alle altre quattro Dignità, rispettivamente dell’Arcidiacono, Cantore, Primicerio e Decano, come gli obblighi ed i diritti connessi alle tre classi ecclesiastiche presenti nella Parrocchia rappresentate rispettivamente dalle Dignità, dai Capitolari semplici e dai Mansionari, come si prevede, nel caso del verificarsi dei possibili eventi ed indisposizioni personali, l’assicurazione della necessaria solidarietà in soccorso del sacerdote bisognoso.
Infine, particolare attenzione viene riservata all’andamento amministrativo della istituzione ecclesiastica. La nomina del Procuratore del Capitolo, l’amministrazione delle rendite parrocchiali, i diversi obblighi ed incombenze richiedono il rispettivo esatto e corretto adempimento da parte degli incaricati, pena le immancabili sanzioni e la minaccia della serenità nello svolgimento della vita del Capitolo parrocchiale. L’esame dei singoli punti, oltre a far comprendere i suddetti aspetti e chiarire le relazioni con l’amministrazione comunale, essendo la chiesa matrice di patronato comunale, contribuiscono ad illuminare tanti particolari altri aspetti della vita sociale di Melpignano.
 Grande
aspirazione del clero melpignanese è cercare di ottenere dalla
santa Sede per la propria chiesa matrice il pieno titolo di collegiata.
L’ultimo in ordine di tempo è il tentativo operato dall’arciprete
Nicola Antonio Oronzo Audilia, autore dei suddetti <<Statuti
e costituzioni>>, il quale, a parte i beni impegnati in opere
di beneficenza in favore di poveri bisognosi, impiega nel suddetto proposito
buona parte del proprio patrimonio. Per raggiungere tale fine il 2 ottobre
1737, il suddetto Arciprete apporta un codicillo al suo testamento
già effettuato per mano del defunto notaio Giuseppe Onorato di
Melpignano. Dispone, infatti, confermando il suo testamento
Grande
aspirazione del clero melpignanese è cercare di ottenere dalla
santa Sede per la propria chiesa matrice il pieno titolo di collegiata.
L’ultimo in ordine di tempo è il tentativo operato dall’arciprete
Nicola Antonio Oronzo Audilia, autore dei suddetti <<Statuti
e costituzioni>>, il quale, a parte i beni impegnati in opere
di beneficenza in favore di poveri bisognosi, impiega nel suddetto proposito
buona parte del proprio patrimonio. Per raggiungere tale fine il 2 ottobre
1737, il suddetto Arciprete apporta un codicillo al suo testamento
già effettuato per mano del defunto notaio Giuseppe Onorato di
Melpignano. Dispone, infatti, confermando il suo testamento
che ... questo suo reverendo Capitolo impetrasse dalla Santa Sede, che questa Chiesa madre oggi ad instar Collegiata, decorarsi pienamente collegiata, come si è tentato, e si spera, vuole che tutti li suoi legati, lasciati con obligo di messe a questo suo reverendo Capitolo, e non gl’altri lasciati fuori del suo testamento, che si applicassero ... nelle [messe] conventuali, tassande dall’Ordinario, come qualità richiesta a tutte le chiese collegiate per decreto della Sacra Congregazione e partecipar i collegiali dell’usufrutto di detti miei legati lasciati per messe basse e conventuali.
Ancora per rendere lustro agli arredi sacri della chiesa matrice si impegna nell’acquisto di nuovi, come per aiutare i giovani melpignanesi nel progresso degli studi non esita a mettere a loro disposizione la propria biblioteca.
L’altra apprezzabile realtà nell’ambito cittadino è rappresentata dal convento dei padri agostiniani dedicato a s. Maria del Carmine. Abbiamo già visto la profonda devozione dei cittadini melpignanesi verso i padri agostiniani e la loro chiesa.
 Con
la costruzione del nuovo convento nel 1638, voluta da padre Raffaele Monosi,
la struttura assurge nell’ambito della provincia agostiniana di Apulia
a figura di primaria importanza diventando anche centro di educandato.
Se la parrocchia raccoglie i giovani più fortunati, potendo le
proprie rispettive famiglie costituire il necessario patrimonio sacro
per garantire la loro ordinazione sacerdotale, il convento apre le sue
porte a quanti sono desiderosi di abbracciare e servire la propria religione
e nello stesso tempo riesce a garantire ai giovani sprovvisti di mezzi
una adeguata istruzione per poter svolgere degnamente il loro impegno
missionario.
Con
la costruzione del nuovo convento nel 1638, voluta da padre Raffaele Monosi,
la struttura assurge nell’ambito della provincia agostiniana di Apulia
a figura di primaria importanza diventando anche centro di educandato.
Se la parrocchia raccoglie i giovani più fortunati, potendo le
proprie rispettive famiglie costituire il necessario patrimonio sacro
per garantire la loro ordinazione sacerdotale, il convento apre le sue
porte a quanti sono desiderosi di abbracciare e servire la propria religione
e nello stesso tempo riesce a garantire ai giovani sprovvisti di mezzi
una adeguata istruzione per poter svolgere degnamente il loro impegno
missionario.
Il giovane entrato nel convento diventato ormai novizio, alla fine del suo tirocinio, affronta il fondamentale momento di far opera di professione. Innanzi tutto il novizio <<non ancora professo nel venerabile convento di S. Agostino della terra di Melpignano>> avanza la sua supplica all'Arcivescovo di Otranto <<come stando per finire l’anno del suo noviziato, doverà fare la sua espressa Professione. E perché desidera fare la rinuncia in conformità del sacro Concilio tridentino in beneficio de’ suoi parenti, però supplica ... concederli la dovuta licenza>>. Secondo l’uso del tempo per la validità dell’atto compiuto, alla presenza del notaio e del regio giudice ai contratti, <<col consenso, autorità, e presenza del molto reverendo padre lettore ... maestro di novizi>>, supplica:
qualmente li mesi passati ispirato da lume divino, avere deliberato di abbandonare il mondo, ed entrare in detto Monistero alfine di osservare le Regole della sua Religione, siccome già per grazia di Dio ritrovandosi averci entrato, e preso lo abito della religione di quello.E perché è tempo di emanare la professione ... dispone di cedere, rinunciare e dona a suo padre ogni parte e porzione legittima a lui spettante.
Ottenuto il consenso dall’Arcivescovo, il giovane novizio può esprimere finalmente il suo atto di professione. Alla presenza del notaio, del giudice ai contratti, e di tutti i suoi superiori, il novizio inginocchiato nel coro della chiesa manifesta la volontà di abbracciare la regola di s. Agostino, <<jurando observare tria vota dictae Religionis, scilicet, castitatem, paupertatem, et obedientiam>>.
Uno sprazzo di luce che contribuisce ad illuminare la vita interna del convento, una sorta di microcosmo in cui le diverse personalità e le esigenze della vita monastica inevitabilmente portano a scontri ed immancabili confronti, sono le vicissitudini personali del padre frà Agostino Politi a testimonianza che il rispetto delle regole della suddetta Congregazione certamente non deve essere tanto semplice, richiedendo ai giovani un forte spirito di sacrificio.
Non sapremo mai a quale delle suddette tre regole è venuto a mancare il detto frate <<il quale per ordine de’ Superiori della di loro Religione si ritrovava in altra camera carcerato, dalla quale mediante sfasciazione della porta di quello dallo stesso machinata, e fatta, si fusse uscito, e fuggito da questo Convento>>, denunciato dal padre baccelliero frà Tommaso Taralli, priore del monastero, e da fra’ Domenico Martelli, terziario e procuratore del detto convento.
 Il
malcapitato fra’ Agostino, come raccontano padre Vincenzo di Soleto, guardiano
del convento dei padri Cappuccini <<della convicina terra di Corigliano>>,
ed il suo compagno frate Giuseppe Maria di Calimera, ai quali si è
rivolto il suddetto frate, <<li quali di propria bocca hanno asserito
in verbo veritatis, che detto fra Agostino Politi, dacchè
fuggi da detto Convento, fusse immediatamente capitato in detto Convento
de’ padri Capoccini di Corigliano ... e dove al presente ritrovasi infermo,
li quali, a’ petizione di detto Politi richiesero alcuni de’ suddetti
mobili bisognanti ad esso fra’
Agostino>>.
Il
malcapitato fra’ Agostino, come raccontano padre Vincenzo di Soleto, guardiano
del convento dei padri Cappuccini <<della convicina terra di Corigliano>>,
ed il suo compagno frate Giuseppe Maria di Calimera, ai quali si è
rivolto il suddetto frate, <<li quali di propria bocca hanno asserito
in verbo veritatis, che detto fra Agostino Politi, dacchè
fuggi da detto Convento, fusse immediatamente capitato in detto Convento
de’ padri Capoccini di Corigliano ... e dove al presente ritrovasi infermo,
li quali, a’ petizione di detto Politi richiesero alcuni de’ suddetti
mobili bisognanti ad esso fra’
Agostino>>.
Ai suddetti frati Cappuccini si consegnano soltanto i vestiti e gli effetti personali <<che sono suoi propri>> e, forse senza astio a significare la serenità di vita esistente nel convento, <<due lanzuoli, che sono di questo ... monastero ... quali mobili tutti si riposero dentro dette bisacce>>.
Qualche giorno dopo Leonardo Za ed Epifanio Bavia, <<mastri d’ascia rispettivamente della terra di Melpignano>>, si presentano al convento e da padre Domenico Taralli, procuratore del Convento,
saliti di unita sopra il dormitorio di detto Convento, furono condotti ad osservare la porta della camera seu cella, che attacca con la Cappella sopra detto stesso dormitorio, che sta nella mano sinistra, quando si sale nel dormitorio suddetto, la quale porta, come li dissero essi priore ... e procuratore ... siccome anche essi dichiaranti avevano inteso dire pubblicamente dalla gente, e per la gente di questa terra, era stata sfasciata dal reverendo padre fra Agostino Politi ex famiglia, che per ordine del di lor molto reverendo Padre Provinciale si ritrovava in questa camera carcerato, ed infatti riconosciuto detta porta, la videro e trovarono ... tutta sfasciata, e che vi mancava una tavola affatto tirata, ed a terra vi era il lucchetto, con cui stava serrata la detta porta, onde essi dichiaranti giusta la di loro perizia, e prattica hanno considerato, che detta sfasciazione, e tiratura di tavola con detto lucchetto fusse stata fatta a’ forza di mani stante che la porta di detta camera era vecchia, perché da molto tempo fatta e perciò deboli le tavole, ed aperta la suddetta fusse uscito.
 Crollato
il sistema feudale come sistema giuridico-politico, grazie alle leggi
ispirate ai principi dell’illuminismo politico, dal nuovo governo rivoluzionario
napoleonico nell’ambito della nuova ristrutturazione della società
secondo modelli borghesi, il cui concetto del bene, svincolato dalla rendita
parassitaria, è legato al fattore di produzione, non legato cioè
alla classe o al ceto sociale privilegiato, oltre ad abolire la feudalità,
con regi decreti 13 febbraio 1807, n. 36, e legge del 7 agosto 1809, n.
448, si sopprimono gli Ordini religiosi possidenti, dando così
un primo colpo al problema della manomorta ecclesiastica. I beni mobili
ed immobili provenienti dai soppressi conventi e monasteri vengono incamerati
nel Demanio dello Stato, il cui patrimonio è posto a garanzia del
debito pubblico e ne costituiscono attraverso le rendite il principale
mezzo di ammortamento. I locali monastici invece, se non venduti, vengono
concessi ai Comuni o ad altri enti, necessari per l’installazione dei
nuovi servizi ad essi affidati, come l’istruzione, l’amministrazione della
giustizia, l’amministrazione comunale o antiche servitù che i cittadini
sono costretti a prestare, quali soprattutto i locali per l’alloggio militare.
Crollato
il sistema feudale come sistema giuridico-politico, grazie alle leggi
ispirate ai principi dell’illuminismo politico, dal nuovo governo rivoluzionario
napoleonico nell’ambito della nuova ristrutturazione della società
secondo modelli borghesi, il cui concetto del bene, svincolato dalla rendita
parassitaria, è legato al fattore di produzione, non legato cioè
alla classe o al ceto sociale privilegiato, oltre ad abolire la feudalità,
con regi decreti 13 febbraio 1807, n. 36, e legge del 7 agosto 1809, n.
448, si sopprimono gli Ordini religiosi possidenti, dando così
un primo colpo al problema della manomorta ecclesiastica. I beni mobili
ed immobili provenienti dai soppressi conventi e monasteri vengono incamerati
nel Demanio dello Stato, il cui patrimonio è posto a garanzia del
debito pubblico e ne costituiscono attraverso le rendite il principale
mezzo di ammortamento. I locali monastici invece, se non venduti, vengono
concessi ai Comuni o ad altri enti, necessari per l’installazione dei
nuovi servizi ad essi affidati, come l’istruzione, l’amministrazione della
giustizia, l’amministrazione comunale o antiche servitù che i cittadini
sono costretti a prestare, quali soprattutto i locali per l’alloggio militare.
Sopravvivono a tali leggi di soppressione soltanto gli Ordini monastici mendicanti, a carico dei quali però vengono applicati diversi ordini di concentramento, di modo che i beni dei diversi conventi e monasteri restano ugualmente a disposizione del Demanio dello Stato.
 Il
convento di s. Agostino viene soppresso in base al suddetto decreto del
7 agosto 1809, il Capitolo parrocchiale di Melpignano invece viene interessato
con l’Unità italiana, quando viene operata un’ulteriore decisiva
ridistribuzione del patrimonio immobiliare ecclesiastico, dalle leggi
di soppressione del 7 febbraio 1861, n. 261, 21 agosto 1862, n. 794, 24
novembre 1864, n. 2006, riguardanti gli enti e beni regolari, ed infine,
per quanto riguarda le chiese recettizie ed i benefici dalle leggi 7 luglio
1866, n. 3036 e 15 agosto 1867, n. 3848.
Il
convento di s. Agostino viene soppresso in base al suddetto decreto del
7 agosto 1809, il Capitolo parrocchiale di Melpignano invece viene interessato
con l’Unità italiana, quando viene operata un’ulteriore decisiva
ridistribuzione del patrimonio immobiliare ecclesiastico, dalle leggi
di soppressione del 7 febbraio 1861, n. 261, 21 agosto 1862, n. 794, 24
novembre 1864, n. 2006, riguardanti gli enti e beni regolari, ed infine,
per quanto riguarda le chiese recettizie ed i benefici dalle leggi 7 luglio
1866, n. 3036 e 15 agosto 1867, n. 3848.
I rinnovati incameramenti di beni, operati ancora una volta a danno delle istituzioni ecclesiastiche, e l'introito realizzato dalla loro vendita, servono esclusivamente a colmare le casse vuote del nuovo Stato italiano. Fatto che penalizza il Sud praticamente ‘spogliato’ di una ricchezza che le era già propria e lo rende ancor più debole di quanto non lo fosse prima. Per quanto riguarda i benefici, le ultime due delle suddette leggi oltre ad affidarne il patrimonio al Fondo per il Culto, successo alla Cassa Ecclesiastica, permettono di esercitare i diritti di rivendicazione o svincolo o di riversione o devoluzione da parte di quei privati che possono esercitare diritti di patronato sugli enti soppressi.
APPENDICE